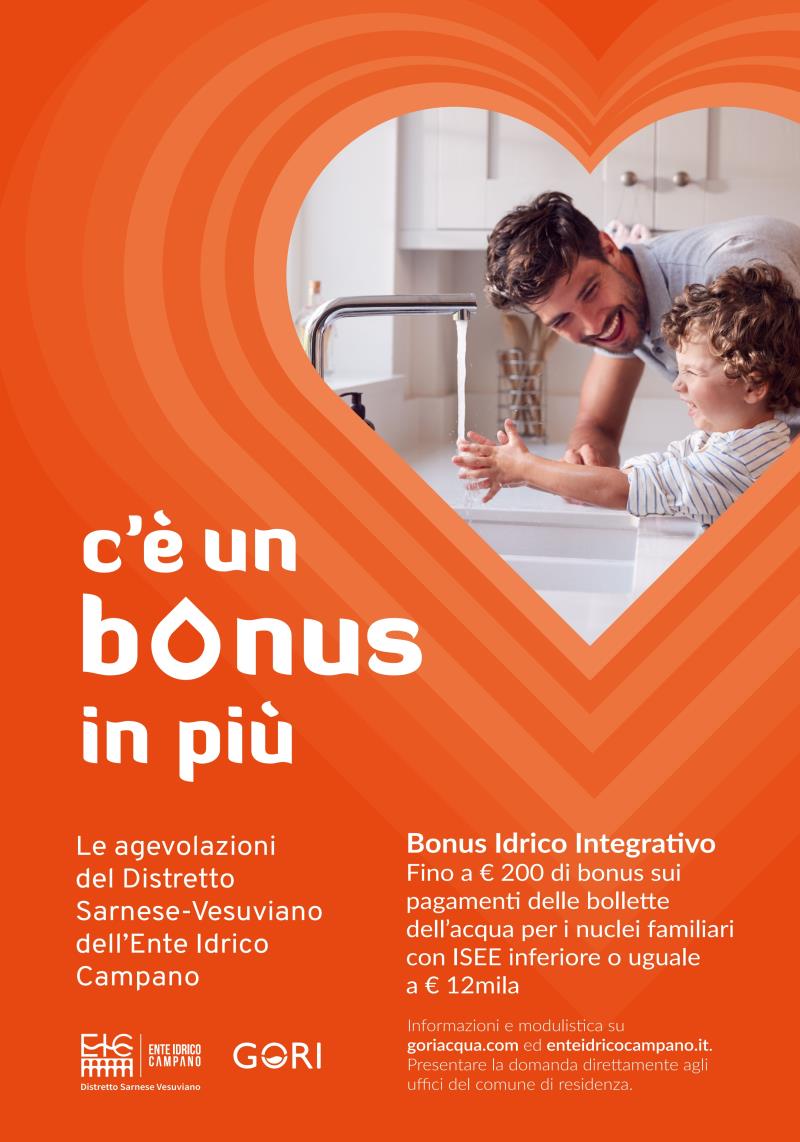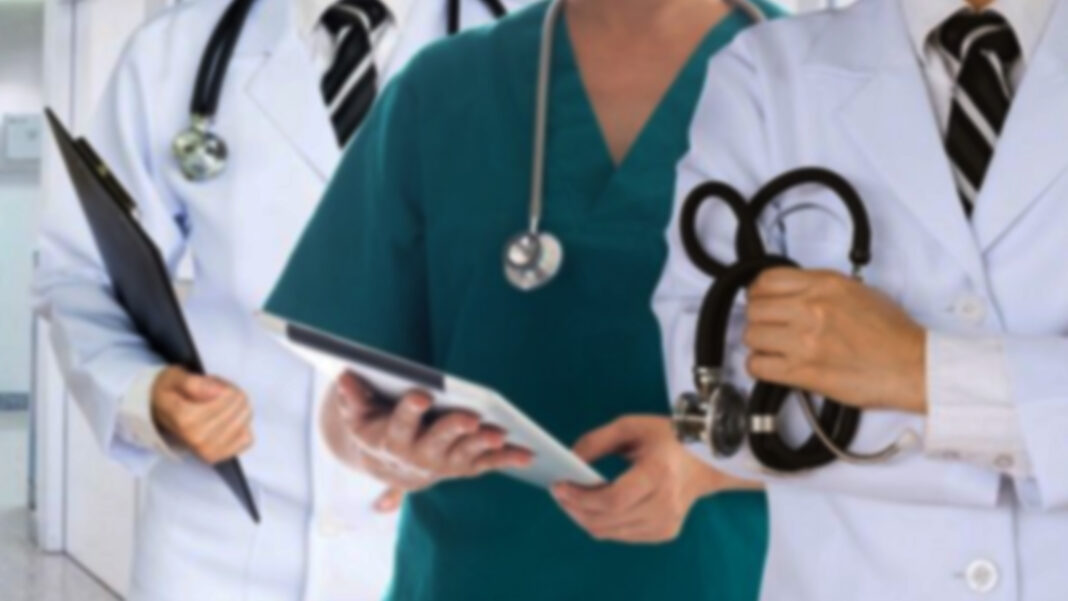Una riforma che promette, ma complica
In Italia servono medici, servono subito e in modo strutturato. I numeri parlano chiaro: ospedali sotto organico, turni massacranti, territori scoperti soprattutto nelle aree periferiche. Eppure, mentre si rincorre la soluzione alla carenza di personale sanitario, il percorso per accedere a Medicina continua a essere tortuoso e selettivo, spesso più ostico che formativo.
La riforma introdotta per l’anno accademico 2025-2026 cambia formalmente le regole d’ingresso, abolendo il test iniziale e aprendo le porte a tutti: un segnale positivo, almeno in apparenza. Gli studenti possono iscriversi online su Universitaly entro metà luglio, scegliendo dieci sedi per Medicina e altre dieci per un corso affine.
Il semestre filtro: una corsa a ostacoli
Dal primo settembre, gli iscritti inizieranno regolarmente le lezioni. Tuttavia, tra fine novembre e inizio dicembre dovranno affrontare tre esami obbligatori (chimica, biologia e fisica) in due appelli. Solo chi otterrà un punteggio elevato potrà continuare nel secondo semestre e iscriversi definitivamente a Medicina. Gli altri saranno dirottati sul corso affine scelto inizialmente. Una soluzione tampone, che garantisce un’alternativa, ma che rischia di lasciare l’amaro in bocca a chi ha investito tempo, energie e sogni.
Il modello italiano resta così fortemente competitivo, ma con una selezione spostata nel tempo che rende l’intero sistema incerto e carico di stress. Una sorta di limbo che non offre subito certezze né agli studenti né alle famiglie, spesso costrette a sostenere spese ingenti per mesi di studio e trasferimenti senza la garanzia del risultato.
Come funziona all’estero: modelli più stabili
Al confronto, molti Paesi esteri adottano modelli più trasparenti e meno penalizzanti. In Francia, ad esempio, dopo la riforma PACES, si accede a Medicina tramite percorsi paralleli ma ben definiti, con criteri chiari fin dall’inizio. In Spagna, l’accesso avviene attraverso un esame nazionale unico (EBAU), con graduatorie basate su criteri meritocratici ma accessibili.
In Germania, il punteggio scolastico e un test attitudinale contribuiscono a definire le posizioni, senza troppe sorprese. In Inghilterra, l’accesso è regolato da un processo complesso ma lineare che prevede test attitudinali (come l’UCAT), colloqui e un dossier personale: un sistema che valuta le reali motivazioni e capacità, non solo la resistenza allo stress accademico.
Un sistema che rischia di perdere i suoi talenti
In Italia, invece, il rischio è quello di tenere tutti dentro per poi escludere in corsa, alimentando frustrazione, incertezza e, spesso, fuga verso l’estero, dove migliaia di giovani italiani scelgono ogni anno di studiare Medicina in università straniere, attratti da percorsi più stabili e coerenti.
La selezione resta necessaria, ma va ripensata. Servono criteri chiari, tempi certi, sostegni concreti. Perché se è vero che formare un medico è complesso, è altrettanto vero che continuare a perdere energie, talenti e fiducia è un lusso che il nostro sistema sanitario non può più permettersi.