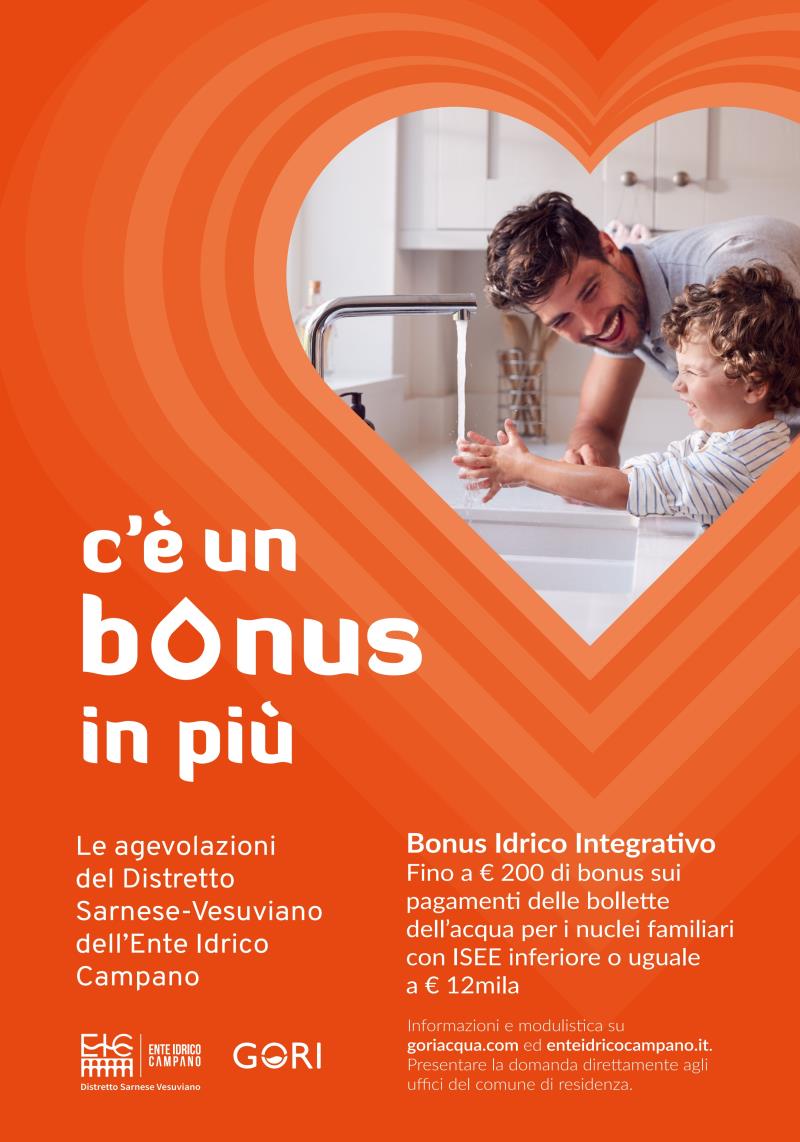Il filo invisibile: Edgar Degas e Angelo Trimarco, l’arte che sopravvive alle mode
Oggi, passando per Piazza del Gesù a Napoli, mi sono imbattuto in Palazzo Pignatelli, un edificio che, nella sua imponenza, ospitò un giovane Edgar Degas durante il suo soggiorno napoletano. Di questo straordinario artista conservo le reminiscenze accademiche e le lezioni mai noiose della professoressa Arcangela Cascavilla. Ricordo bene come ci incoraggiava a immergerci nelle opere dei grandi pittori moderni, trasmettendoci un amore viscerale per gli impressionisti, tra cui spiccava Hilaire-Germain Edgar Degas.
Connessioni
Questa visita è stata permeata da una nota di malinconia per la recente scomparsa del professore Angelo Trimarco, intellettuale di grande spessore e preside all’Università di Salerno. Scomparso il 5 novembre 2024, Trimarco lascia un vuoto nel mondo accademico e culturale. La sua lunga carriera non si è limitata all’insegnamento e alla ricerca; egli vestì anche i panni di giornalista, raccontando la vibrante scena culturale di Napoli. Ha dedicato la vita all’arte e alle sue mutevoli forme, e il suo contributo è tangibile nei numerosi saggi, monografie e mostre che ha curato. Oggi, quasi come per destino, Degas e Trimarco mi sono sembrati legati da un filo sottile, uniti nella testimonianza di quanto la cultura possa trascendere le mode effimere.
Edgar Degas e il legame con Napoli
La connessione tra Degas e Napoli ha radici profonde. Il nonno paterno di Degas, René Hilaire, trovò rifugio a Napoli durante la Rivoluzione Francese. Qui fondò una banca, diventando il banchiere di Gioacchino Murat e incrementando considerevolmente la propria fortuna. Sposò Giovanna Teresa Freppa, una livornese, e con lei ebbe sette figli, tra cui Auguste, il papà di Edgar.
Le radici
Queste radici partenopee, sono probabilmente alla base della decisione di Edgar Degas di inaugurare il suo “grand tour” proprio a Napoli. Giunto nel 1856, Degas si ricongiunge con il nonno e viene ospitato nel palazzo di famiglia, Palazzo Pignatelli di Monteleone. In quegli anni, Napoli era una delle città culturalmente più vivaci del mondo, e il giovane artista approfittò di questa effervescenza per affinare la propria tecnica. Frequentava l’Accademia di Belle Arti, il Museo Archeologico Nazionale e quello di Capodimonte, e coltivava amicizie nel mondo dell’arte, come quella con Filippo Palizzi. Durante quei mesi, dipinse il “Ritratto di Hilaire De Gas”, un’opera raffigurante il nonno e considerata il primo lavoro di rilievo di Degas.
In questo itinerario della memoria, Palazzo Pignatelli, lo stabile delle cento stanze, diventa un punto di connessione tra passato e presente, tra artisti e intellettuali separati dai secoli, ma accomunati da una dedizione incrollabile all’arte che, anche oggi, continua a vivere e a nutrirsi della cultura di Napoli.
Un periodo di fervore culturale: Trimarco e la scena artistica di Napoli
In linea d’aria, nel breve raggio della Napoli che si affaccia sui Decumani, Angelo Trimarco viveva una delle sue stagioni culturalmente più intense, come sottolinea Renata Caragliano. È un periodo in cui Napoli e dintorni vedono un fiorire di iniziative artistiche e culturali che ne ridefiniscono il panorama. Nel 1963, in questo clima di rinnovamento, nasce a Port’Alba la Libreria-Galleria Guida, con la leggendaria Saletta Rossa. Questo spazio, sostenuto da figure come Pellegrino Sarno e Achille Bonito Oliva, diventa nel corso di un decennio il punto d’incontro per mostre, dibattiti e incontri di rilievo internazionale in ambito artistico, letterario e filosofico.
Bonito e Sinisi
Poco dopo, nel 1965, fa il suo ingresso Lucio Amelio con la Modern Art Agency a Parco Margherita 85, inaugurata con una personale di Heiner Dilly dal titolo emblematico, Racconti di viaggio. Nello stesso anno, un’altra figura fondamentale entra sulla scena: Filiberto Menna, chiamato a Salerno per insegnare Storia dell’Arte al Magistero e divenuto critico d’arte per Il Mattino. È proprio in quel periodo che Trimarco, suo assistente, collabora con Menna anche nel lavoro giornalistico, mentre compagni di studi come Achille Bonito Oliva e Silvana Sinisi contribuiscono ad arricchire questo fervido ambiente accademico.
Trimarco, ricordando quegli anni, afferma: “Ho compagni di cordata, all’università, Achille Bonito Oliva e Silvana Sinisi.” Un legame che ha segnato non solo il suo percorso, ma un’intera epoca di cambiamento culturale.
Nota a margine. La mia è una personale interpretazione senza alcuna velleità critica e comparatistica.