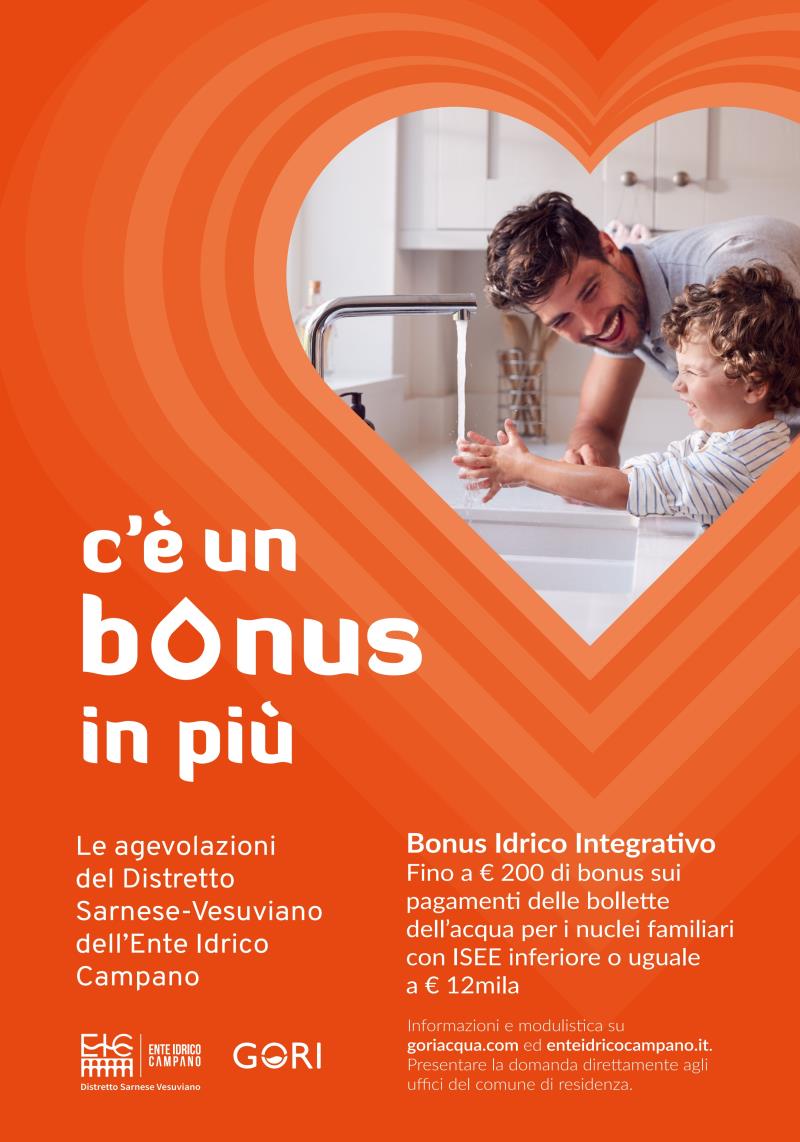Pomodoro, al via la campagna estiva nell’agro nocerino sarnese: memoria, produzione e crisi di un simbolo identitario
Luglio inoltrato, cielo terso e campi che iniziano a tingersi di rosso. Nell’agro nocerino sarnese e nella zona vesuviana, questo è il periodo dell’anno in cui si risveglia una delle tradizioni agricole più identitarie del territorio: la raccolta del pomodoro, in particolare quello San Marzano, per decenni emblema della ruralità meridionale e oggi fragile icona rara di una filiera in crisi. Inizia così, tra attese e preoccupazioni, la nuova campagna del pomodoro, che si consumerà come ormai da diversi anni in poco più di quaranta giorni, segno di una stagione sempre più compressa e vulnerabile.
Il cuore agricolo di un territorio
A cavallo tra gli anni Cinquanta e Settanta, l’Agro era considerato la “Lione” dell’agroalimentare italiano. Qui, nel solco della fertilissima pianura vesuviana, nacque il modello di una filiera corta ante litteram, in grado di coniugare coltivazione, trasformazione e commercializzazione del pomodoro. Il pomodoro San Marzano, con il suo profilo allungato, la buccia sottile e la polpa compatta, divenne il simbolo per eccellenza di una tradizione contadina sapiente, fatta di quelle mani callose, terre laviche e acqua ricca di minerali, dell’humus fertile.
Le stagioni d’oro del raccolto
Il fino agli anni ottanta il pomodoro veniva coltivato in ogni angolo utile: dai fondi pianeggianti di Nocera Inferiore e Angri alle terre scure di San Marzano sul Sarno, da dove prende il nome la varietà più celebre. Ma accanto al San Marzano convivevano anche altre cultivar autoctone: il pomodorino Corbarino, coltivato sulle pendici dei Monti Lattari, dal sapore dolce e persistente, e il ciliegino del Vesuvio, piccola gemma dal sapore inconfondibile e aromatico, raccolto su terreni di origine vulcanica tra Terzigno, San Giuseppe Vesuviano e Boscoreale.
Il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio oggi con denominazione DOP resta certamente uno dei simboli più antichi dell’agricoltura campana, citato anche nelle iconiche e rappresentative scene del tradizionale presepe napoletano. Coltivato da secoli sulle fertili pendici del Vesuvio, è frutto della selezione naturale di antichi ecotipi locali come “Fiaschella”, “Lampadina”, “Patanara”, “Principe Borghese” e “Re Umberto”, tramandati tra generazioni. Quello che lo rende unico e rappresentativo è il metodo tradizionale di conservazione: i pomodorini vengono raccolti in grappoli e appesi a formare i tipici “piennoli”, restando intatti per mesi grazie al clima vulcanico e alla loro rusticità. Fattori che caratterizzano questa risorsa agricola, rubricandolo come patrimonio culturale e gastronomico del territorio vesuviano.
Una filiera che resiste tra mille difficoltà
Oggi quella stagione epica fatta di fatiche e raccolti che coinvolgeva un ampio strato sociale resta soltanto memoria di una generazione. Il settore agro alimentare e del pomodoro è segnato da una profonda crisi: la riduzione drastica delle superfici coltivate, l’aumento dei costi energetici e logistici, il peso delle intermediazioni, la scarsità di manodopera stagionale regolare, e la concorrenza sleale di produzioni estere che, pur non rispettando gli stessi standard qualitativi, invadono il mercato a prezzi più bassi.
A questo si aggiunge la drammatica compressione dei tempi di lavorazione: la campagna del pomodoro, un tempo distribuita su due mesi pieni, oggi si è ridotta a una finestra operativa di poco più di quaranta giorni, concentrata tra la seconda metà di luglio e l’inizio di settembre. Ciò mette sotto pressione l’intera filiera della trasformazione, che deve gestire in poche settimane migliaia di tonnellate di prodotto, rischiando spesso l’abbassamento degli standard qualitativi e lavorativi.
Una scommessa tra memoria e futuro
Tra i solchi della storia agricola dell’Agro, il pomodoro continua a essere un riferimento culturale prima ancora che economico. È l’ingrediente identitario per eccellenza, quello che finisce in ogni sugo domenicale, in ogni barattolo è una testimonianza generazionale, un racconto familiare. Un simbolo che non può essere abbandonato al destino della crisi o delle logiche industriali.
La sfida oggi è duplice: valorizzare il patrimonio di biodiversità e saperi locali, sostenendo i piccoli produttori, e al tempo stesso ripensare il sistema agricolo in chiave sostenibile, puntando su certificazioni attendibili, tracciabilità, filiere corte e tutela del lavoro. Il rosso del pomodoro ha raccontato per decenni la dignità del lavoro agricolo e la forza identitaria di un territorio, al quale oggi è necessario dare un senso nuovo, che non sia solo nostalgia del passato, ma una forte base di rinascita anche produttiva fatta di intelligenza e di visione.
Campania in fiamme: il clima estremo alimenta nuovi roghi (video)